Una fortezza militare nascosta tra le rocce di Capo d’Orso. Dove oggi passano gli yacht, un tempo c’erano le navi da guerra.

Fortezza Capo d’Orso, Palau
VAI ALLA GALLERY
Oggi è uno dei centri del del turismo sardo e uno dei paesaggi più spettacolari dell’isola, ma negli ultimi due secoli e mezzo il tratto di costa compreso tra Palau e l’arcipelago della Maddalena è stato uno dei punti strategici di quel complicatissimo scacchiere geopolitico che era il Mediterraneo. Le acque che che venivano solcate dapprima dai vascelli sabaudi, francesi e inglesi, dagli incrociatori italiani e infine dai sottomarini nucleari americani, sono oggi dominio incontrastato dei battelli che ripercorrono incessanti la tratta per l’isola di La Maddalena e, durante i mesi estivi, degli yacht e dei barconi carichi di turisti.
Le guerre sono finite e anche qui i militari hanno fatto le valigie, ma l’imponente sistema di fortificazioni che ci ricorda lo spettro sempre presente della follia e dell’aggressività umana è ancora lì, a due passi da hotel, piscine, ville da sogno e villaggi vacanze. Paradisi artificiali il cui numero sembra comunque relativamente contenuto rispetto ad altre aree della Costa Smeralda. Qui la cementificazione selvaggia è stata limitata anche dalle piazzeforti militari.
Tra le tante fortificazioni militari presenti in Sardegna, la postazione di Palau merita un’attenzione particolare sia per le dimensioni, sia per il suo ruolo storico nella difesa da un ipotetico tentativo di invasione dell’Isola. Invasione che non c’è mai stata, ma la fortezza ha continuato ad esistere e ad aspettare, quasi come quella immaginata dallo scrittore Dino Buzzati nel suo romanzo “Il deserto dei Tartari”.
A causa della sua particolare posizione geografica (e conformazione fisica), la Sardegna ha ricevuto l’ingrato nominativo di “portaerei del Mediterraneo”. Ma già più di un secolo prima dell’avvento della guerra moderna, gli strateghi militari avevano già puntato gli occhi sull’isola. Nel 1793, durante il Regno dei Savoia, l’arcipelago della Maddalena e la costa antistante furono teatro di un fallito tentativo di invasione da parte della flotta francese – a cui partecipò tra gli altri il giovane Napoleone Bonaparte – respinto dall’ammiraglio maddalenino Domenico Millelire. Successivamente l’ammiraglio inglese Horatio Nelson, consapevole del pericolo francese, scrisse:
“…se noi possiamo possedere la Sardegna non avremmo più bisogno né di Malta né di altro: essa, quale stazione navale e militare, è la più importante isola del Mediterraneo: possiede alla sua estremità settentrionale il più bel porto del mondo. La Maddalena è a 24 ore di vela da Tolone; copre l’Italia e la sua posizione è tale che il vento favorevole ai Francesi per navigare verso est è egualmente propizio a noi per seguirli [...]. Se io perdo la Sardegna perdo la flotta francese”.
Pertanto, nel 1803, Nelson elegge quel tratto di mare come base della Marina inglese, il che fece desistere i Francesi da ulteriori tentativi di sbarco.
Proprio in questo periodo emerse la necessità di potenziare la rete di vedette costiere con un complesso sistema di fortini e caserme. Nacquero, tra le altre, le fortezze di punta Altura e di Capo d’Orso, e le postazioni di Montiggia e punta Sardegna. Inizialmente di piccole dimensioni, vennero progressivamente ampliate nel corso dei successivi anni di relativa calma.

Galleria, Fortezza Capo d’Orso
Nel 1851, subito dopo la prima Guerra d’Indipendenza, i Savoia inviarono a Palau il Generale Verani, che esaminò il sistema difensivo ipotizzando lo scenario di una nuova invasione della Sardegna. Giunto alla conclusione che l’asprezza dell’entroterra gallurese avrebbe costituito già di per sé una difesa naturale contro un eventuale nemico, propose di concentrare la presenza militare solo sulla costa, rafforzando selettivamente alcune delle preesistenti installazioni. Venne data la priorità al forte di Capo d’Orso, per la sua posizione che permetteva di spaziare sul golfo di Arzachena e su La Maddalena e Caprera. Tuttavia, a causa della mancanza di fondi deputati al potenziamento delle strutture, nel 1857 il governo sabaudo fu costretto a decretarne l’abbandono.
Trent’anni più tardi, nel 1887, con il cambiamento dello scenario geopolitico locale e l’introduzione di armi sempre più distruttive, si tornò a riconsiderare il concetto di fortificazione costiera: il nuovo obiettivo strategico non era più la difesa della Sardegna, ma il controllo delle Bocche di Bonifacio. Per questo motivo, anche Capo d’Orso venne recuperata e assunse un “ruolo attivo”: il che, tradotto dall’asettico lessico militare, equivale a dire che le installazioni si dotarono di artiglieria in grado di colpire le navi anche su lunghe distanze.
La fortezza venne ampliata con la costruzione di una nuova caserma con capienza di cinquanta uomini, e altri edifici (tra cui scuderie e una polveriera) verso l’entroterra. Venne largamente utilizzata la pietra locale, il granito, che offriva agli edifici sia una grande resistenza, sia una mimetizzazione con il paesaggio circostante. Si riparlò anche di un’invasione che, sempre secondo gli strateghi, avrebbe potuto seguire il tracciato della nuova strada Palau-Tempio, per cui un ulteriore obiettivo del forte era proprio la difesa di Palau. Per l’epoca, queste installazioni rappresentavano l’apice della tecnologia conosciuta in termini di difesa costiera. Fortunatamente, i cannoni tacquero e per la batteria di Capo d’Orso non si presentarono occasioni per partecipare ad azioni belliche.
Durante la Prima Guerra Mondiale il conflitto si tenne al di fuori della Sardegna, ma le fortezze di Palau vennero ulteriormente rinforzate e mimetizzate, nell’eventualità di incursioni aeree. Le ostilità arrivarono invece con la Seconda Guerra Mondiale, in cui Capo d’Orso ricoprì un ruolo primario nella difesa del porto di La Maddalena, di vitale importanza per le navi della Regia Marina italiana. Pesantemente equipaggiata con cannoni e mitragliatrici antiaeree, non riuscì a impedire il bombardamento alleato che nell’aprile del 1943 portò all’affondamento del famoso incrociatore “Trieste”, in rada nelle acque antistanti all’isola.
Dopo la fine della guerra, nonostante la massiccia presenza statunitense nell’arcipelago della Maddalena, tutte le fortificazioni di Palau persero ogni importanza e vennero lentamente abbandonate. Negli ultimi decenni l’area è passata dalla Marina allo Stato, che a sua volta l’ha ceduta alla Regione, senza che al momento vi sia un preciso piano di ristrutturazione o valorizzazione (come è invece avvenuto, ad esempio, per punta Altura).
Oggi le rovine di Capo d’Orso si trovano a poche centinaia di metri dalla celebre roccia omonima, meta di migliaia di visitatori. Per merito della robustezza del granito, la struttura si è preservata in condizioni relativamente buone, nonostante la ruggine e l’umidità abbiano in gran parte minato l’integrità degli elementi in ferro e legno. Aggirandosi tra l’intricato labirinto di gallerie, camminamenti e ponti sospesi che compongono questo imponente scheletro di pietra, si ha l’impressione di trovarsi in un una strana via di mezzo tra un castello medievale e un tempio precolombiano.
Nella parte più interna si trovano il caratteristico ponte di ingresso, le caserme, le scuderie e gli edifici che probabilmente erano le polveriere, ormai invasi dalla macchia mediterranea. Risalendo il sentiero si arriva a quota 109 metri, dove si apre un piazzale che domina l’arcipelago, con le vecchie postazioni dell’artiglieria ancora in attesa di un invasore che fortunatamente non arrivò. E a questo punto, forse, possiamo dire che non arriverà mai.
DOVE SI TROVA: a Capo d’Orso, nei pressi di Palau, di fronte all’isola di Santo Stefano e de La Maddalena. Ci si arriva dal sentiero che parte dalle indicazioni per la roccia dell’orso (l’orso è sulla sinistra, la fortezza sulla destra). Google Maps.
Foto














































 Con 450 lire, pagabili a rate in 15 anni, si diventa soci della cooperativa. Si costruiscono le strade, vengono dissodati 200 ettari di terreni e innalzati i muri di recinzione. Le coltivazioni prevedono una rotazione quinquennale di orzo, grano, avena, granturco e fave. Viene predisposto l’impianto per un allevamento di bachi da seta. L’edificio principale è quello che ospita gli operai. Nella borgata non manca niente: ambulatorio medico, scuola elementare (non solo per i bambini ma anche per gli adulti, visto l’alto tasso di analfabeti), laboratori, magazzini, caseifici, officine e ovviamente anche una chiesa, dal curioso impianto circolare.
Con 450 lire, pagabili a rate in 15 anni, si diventa soci della cooperativa. Si costruiscono le strade, vengono dissodati 200 ettari di terreni e innalzati i muri di recinzione. Le coltivazioni prevedono una rotazione quinquennale di orzo, grano, avena, granturco e fave. Viene predisposto l’impianto per un allevamento di bachi da seta. L’edificio principale è quello che ospita gli operai. Nella borgata non manca niente: ambulatorio medico, scuola elementare (non solo per i bambini ma anche per gli adulti, visto l’alto tasso di analfabeti), laboratori, magazzini, caseifici, officine e ovviamente anche una chiesa, dal curioso impianto circolare. Insomma, va tutto a gonfie e vele. Fino al 1913, quando Perussia viene colpito da un ictus. Morirà due anni dopo, lontano dalla Sardegna e da Surigheddu. Con la sua morte Surigheddu non muore ma cambia un po’ il suo aspetto: gli operai non sono più soci, ma diventano dipendenti con contratti di mezzadria.
Insomma, va tutto a gonfie e vele. Fino al 1913, quando Perussia viene colpito da un ictus. Morirà due anni dopo, lontano dalla Sardegna e da Surigheddu. Con la sua morte Surigheddu non muore ma cambia un po’ il suo aspetto: gli operai non sono più soci, ma diventano dipendenti con contratti di mezzadria.










































 In origine era costituito da 14 padiglioni, collegati tra loro da un lungo corridoio centrale vetrato, ad anello. Nell’edificio principale, sul lato ovest, vi era la sede della direzione, i laboratori e gli alloggi per medici, infermieri e suore. Gli altri caseggiati a un piano erano divisi tra le varie infrastrutture e i reparti di degenza, per un totale circa 300 posti letto (150 uomini e altrettante donne), a cui si aggiunsero altri 70 letti per bambini pochi anni più tardi.
In origine era costituito da 14 padiglioni, collegati tra loro da un lungo corridoio centrale vetrato, ad anello. Nell’edificio principale, sul lato ovest, vi era la sede della direzione, i laboratori e gli alloggi per medici, infermieri e suore. Gli altri caseggiati a un piano erano divisi tra le varie infrastrutture e i reparti di degenza, per un totale circa 300 posti letto (150 uomini e altrettante donne), a cui si aggiunsero altri 70 letti per bambini pochi anni più tardi.

















































































































































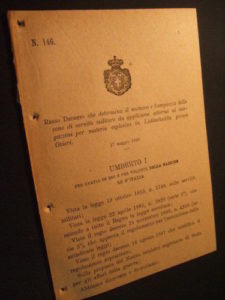




























































































































































 A valle della diga venne costruita la centrale idroelettrica, e grazie ad essa Ulà Tirso fu il primo paese della Sardegna ad avere l’energia elettrica. All’epoca, e per molto tempo, l’Omodeo era il lago artificiale più grande d’Europa, come tutti i bambini sardi, per decenni, hanno imparato a memoria sui libri di scuola.
A valle della diga venne costruita la centrale idroelettrica, e grazie ad essa Ulà Tirso fu il primo paese della Sardegna ad avere l’energia elettrica. All’epoca, e per molto tempo, l’Omodeo era il lago artificiale più grande d’Europa, come tutti i bambini sardi, per decenni, hanno imparato a memoria sui libri di scuola.













































![Digvecch[1]](http://www.sardegnaabbandonata.it/wp-content/uploads/2014/09/Digvecch1-150x150.jpg)



















































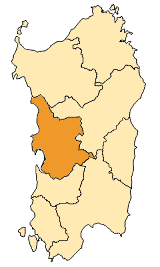 Vista la loro esigua resistenza alle offese avversarie, la possibilità di sfuggire all’osservazione era essenziale.
Vista la loro esigua resistenza alle offese avversarie, la possibilità di sfuggire all’osservazione era essenziale.









































































































































 Pensavamo di aver visto ormai tutto nei dintorni del lago Omodeo, e invece no. Troppa storia, e troppo lunga, per non aver lasciato decine di tracce abbandonate e spesso nascoste.
Pensavamo di aver visto ormai tutto nei dintorni del lago Omodeo, e invece no. Troppa storia, e troppo lunga, per non aver lasciato decine di tracce abbandonate e spesso nascoste. 


































































































































































































































































































































